Made Expo 2025 si prepara a tornare dal 19 al 22 novembre presso Fiera Milano, confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato all’architettura, all’edilizia e all’innovazione del costruito.
Questa edizione si annuncia come un vero e proprio laboratorio di idee, dove protagonisti internazionali, nuove tecnologie e visioni strategiche si incontrano per ridefinire il futuro del settore. In un momento storico in cui il mondo delle costruzioni è attraversato da profonde trasformazioni — tra sostenibilità, digitalizzazione e inclusività — Made Expo propone un programma ricco di talk, incontri e contenuti ad alto impatto, pensati per offrire strumenti concreti ai professionisti.
AI Architectural Intelligence
Tra gli appuntamenti da non perdere, il 20 novembre alle ore 9.30 si terrà “AI Architectural Intelligence”, una conversazione ad alto livello sull’intelligenza artificiale applicata all’architettura e all’edilizia. Un tema sempre più centrale, che sta rivoluzionando il modo di progettare, costruire e gestire gli spazi urbani.
Dai droni utilizzati per il monitoraggio dei cantieri alla progettazione generativa, dalla manutenzione predittiva dei patrimoni immobiliari fino all’ottimizzazione della supply chain: i campi di applicazione sono molteplici e destinati a crescere.
A guidare la riflessione saranno due figure diverse ma complementari: Neal Leach, architetto e professore universitario, da anni impegnato nello studio dell’intersezione tra design e nuove tecnologie, e Luca Sassi, architetto e content creator, capace di tradurre i linguaggi complessi dell’innovazione in strumenti narrativi immediati e accessibili.
Il dialogo tra i due offrirà una prospettiva inedita, in grado di coniugare la profondità della ricerca accademica con l’esperienza diretta di chi vive quotidianamente la trasformazione digitale dei processi progettuali.
New European Bauhaus
Ma l’intelligenza artificiale sarà solo il primo passo di un percorso più ampio: tutti gli eventi di Made Expo saranno infatti accomunati dai valori del New European Bauhaus (Neb), l’iniziativa europea che invita architetti, ingegneri e costruttori a ripensare gli spazi in chiave di sostenibilità, bellezza e inclusività.
La sostenibilità sarà declinata in una serie di incontri dedicati ai materiali innovativi, al ciclo di vita degli edifici e alle nuove pratiche di economia circolare: temi cruciali in un’epoca in cui l’impatto ambientale è diventato parte integrante delle decisioni di progetto.
Il tema della bellezza verrà affrontato con focus su design, comfort abitativo e qualità architettonica, per sottolineare come il costruire non possa limitarsi a risolvere problemi tecnici, ma debba generare valore estetico e culturale per la comunità.
Infine, l’inclusività guiderà le riflessioni su accessibilità, diversità e coesione sociale: un invito a immaginare spazi urbani e abitativi capaci di rispondere alle esigenze di tutte le persone, rafforzando il ruolo dell’architettura come strumento di equità.
Il palinsesto di Made Expo diventa così una piattaforma di dialogo che mette insieme tecnologia e valori, innovazione e tradizione, mercato e visione.
Per i professionisti che parteciperanno, non sarà soltanto un’occasione di aggiornamento, ma anche un’esperienza culturale che restituisce alla costruzione il suo ruolo di motore di progresso per l’intera società.
Per restare aggiornati sul palinsesto degli eventi clicca qui Calendario Eventi.
In un contesto che premia la visione e la progettualità, Made expo 2025 intende intercettare e sostenere i segnali più dinamici del mercato.
Mercato della riqualificazione
Se da un lato il mercato della riqualificazione edilizia segna il passo, dall’altro il mercato delle costruzioni continua invece ad essere trainato dagli investimenti in opere pubbliche che, secondo i dati forniti da cresme in esclusiva per Made Expo, nel 2025 toccheranno l’eccezionale valore di quasi 78 miliardi di euro a valori correnti.
Si tratta di un’ulteriore crescita del 7,5% a valori deflazionati, dopo quella del 13,8% del 2024 e quella del +23% del 2023.
Made expo 2025, organizzato da Made eventi srl, società di Fiera Milano Spa e Federlegno Arredo Eventi spa, nasce per rispondere a una necessità concreta: offrire una piattaforma evoluta dove innovazione, sostenibilità e cultura del costruire si fondono in un’unica visione.
Salone involucro e Salone costruzioni
Il Salone Involucro si concentrerà sull’esposizione di serramenti, finestre e porte; facciate e coperture; componenti e accessori; chiusure e soluzioni per l’oscuramento e l’automazione; schermature solari e anti-insetto.
Il Salone Costruzioni, invece, porterà in fiera software e tecnologie per la progettazione e il Building Information Modeling (Bim), ma anche prodotti e servizi per strutture, infrastrutture e sistemi costruttivi; attrezzature per il cantiere; proposte per la riqualificazione energetica, il restauro, la sicurezza e l’isolamento termico e il comfort
Un progetto condiviso che attrae eccellenze e crea opportunità concrete
Quattro padiglioni e oltre 600 aziende animeranno l’evento, tra cui grandi rientri nella filiera dell’alluminio, che scelgono di essere presenti e investire sul progetto Made expo.
Oltre a queste, molte nuove realtà di eccellenza nei serramenti e nell’outdoor sistemi costruttivi innovativi e materiali performanti per l’edilizia che debutteranno per la prima volta.
Un segnale chiaro e potente: il mercato riconosce la manifestazione come punto di riferimento imprescindibile per visione, contenuti e impatto. Made expo attrae chi vuole contare, e aggrega chi vuole costruire davvero il futuro del settore.
A sostegno della manifestazione, la collaborazione con Ice- Agenzia che attiverà un articolato Buyer Program volto a favorire l’incoming dei più importanti operatori internazionali del settore.
Il programma prevede un’attività di scouting mirata nei principali mercati esteri e la definizione di agende personalizzate, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro concrete e mirate.
Un’iniziativa strategica pensata per intercettare le esigenze degli espositori e massimizzare le opportunità di business all’interno della manifestazione.
Un ecosistema di conoscenza e innovazione
Più che una fiera, MADE expo è un’intelligenza collettiva che alimenta cultura progettuale e strategia industriale.
Con il supporto di knowledge partner di rilievo come il Politecnico di Milano e Cresme, la manifestazione si conferma una piattaforma di pensiero, capace di generare insight, scenari evolutivi e strumenti operativi per tutta la filiera.
A MADE Expo si incontrano sapere tecnico e visione sistemica, ricerca e impresa anche grazie alle partnership con le più prestigiose associazioni di categoria come UNICMI, Federparquet e Confartigianato, Conpaviper, Anit e Assorestauro.
Completano il quadro delle collaborazioni Fondazione Eucentre, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Grazie a queste collaborazioni tra soggetti diversi ma complementari, MADE Expo si presenta come una manifestazione trasversale, dinamica e orientata al risultato.
Una piattaforma internazionale, un linguaggio europeo
Made expo parla al mondo e lo fa con autorevolezza. Grazie alla collaborazione con il New European Bauhaus il movimento promosso dalla Commissione Europea per un’architettura sostenibile, bella e inclusiva l’edizione 2025 sarà profondamente connessa ai grandi temi continentali.
Una traiettoria culturale e politica che si concretizza anche nella nascita del Made Sustainable Award, il riconoscimento che premia le eccellenze progettuali nel campo della sostenibilità.
Sostenibilità: una scelta identitaria
Per Made expo, la sostenibilità non è un tema tra gli altri: è un principio guida, una responsabilità condivisa e una scelta identitaria.
L’accordo con Green Building Council Italia, membro del World Gbc, la più grande rete globale dedicata all’edilizia sostenibile, presente in oltre 80 Paesi, consolida questa direzione e rafforza il ruolo della manifestazione come fulcro italiano della transizione sostenibile nell’edilizia. Un impegno concreto che si esprime a tutti i livelli: ambientale, economico e sociale.
Dove si costruisce il futuro, davvero
Made expo 2025 sarà il luogo dove imprese, professionisti, istituzioni e centri di ricerca si incontrano per costruire insieme nuove traiettorie di sviluppo. Non solo una vetrina d’eccellenza, ma una vera e propria infrastruttura di dialogo, progettazione e innovazione collettiva anche grazie a un palinsesto di eventi e convegni ricco e completo che tratterà tra gli altri i seguenti temi: intelligenza artificiale in architettura, social housing, strumenti e soluzioni di trasformazione delle città, architettura sostenibile, rigenerazione urbana e politiche locali per la sostenibilità.




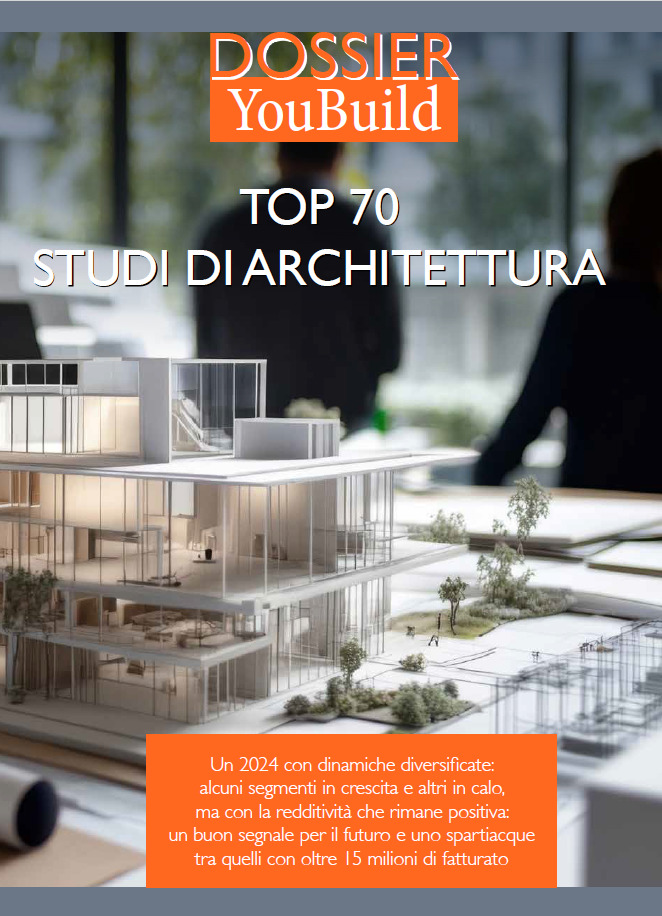






















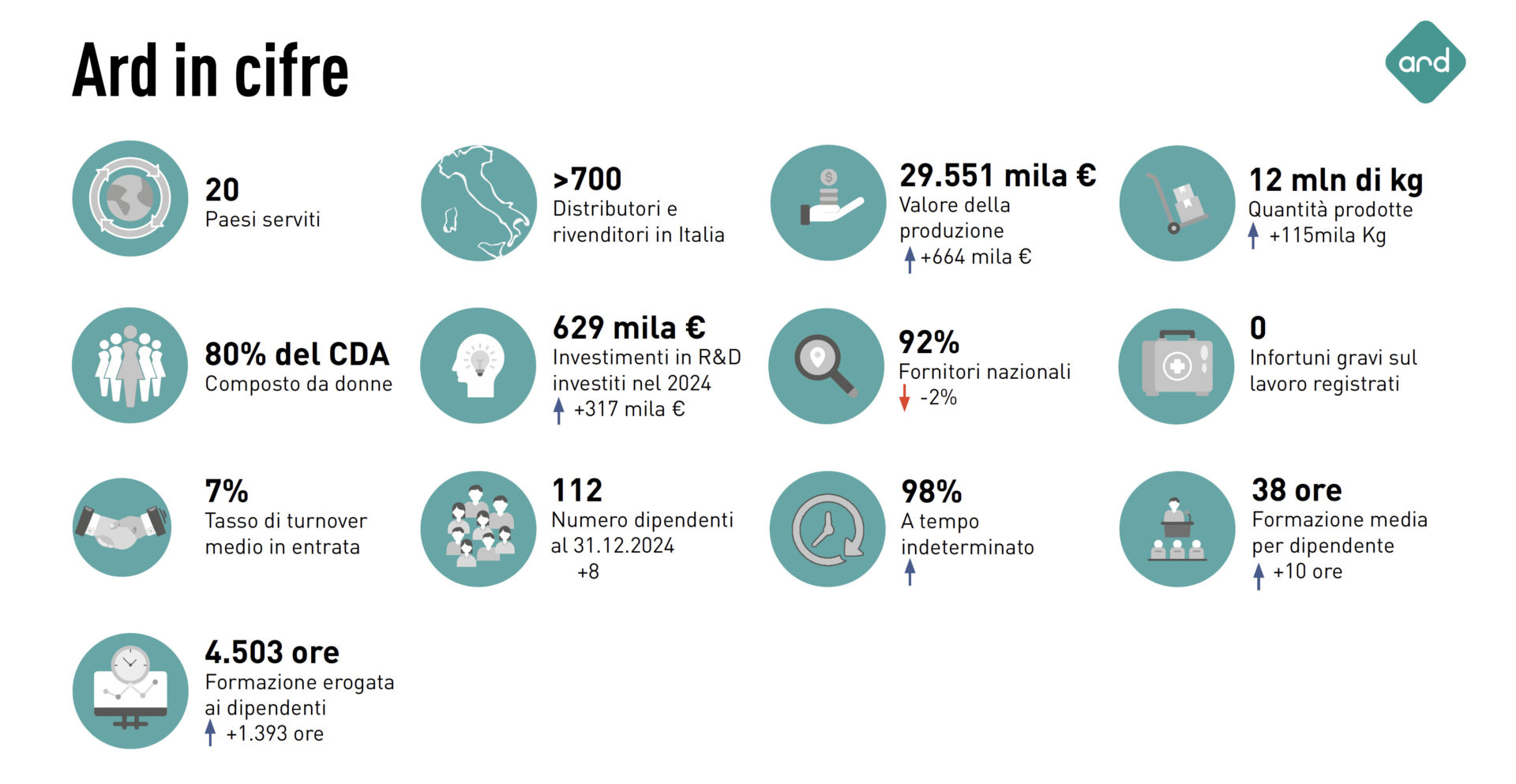



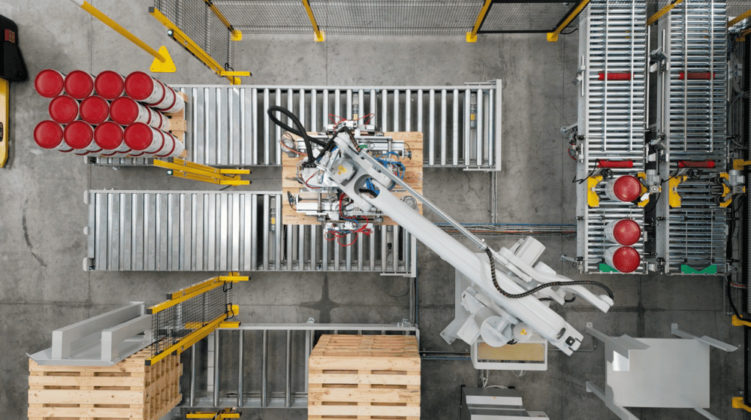







Energia, Italia stretta tra Usa e Cina
Ogni tanto anche chi bada quotidianamente al proprio lavoro o al proprio business farebbe bene ad alzare la testa per guardare l’orizzonte. No, non per una pausa in vista di un selfie con alle spalle un tramonto o un paesaggio pittoresco. L’orizzonte, in senso figurato, è quello che concerne i grandi trend che muovono e a volte sconquassano il mondo. Uno di questi riguarda da vicino il mondo dell’edilizia ed è quello della transizione green. L’Europa è la protagonista nel processo di riduzione delle emissioni, sia per quanto riguarda il settore automotive sia per quello delle costruzioni, con la direttiva Epbd che deve (o dovrebbe) spingere a una radicale riqualificazione degli edifici.
Ma c’è chi, anche in Italia, è contrario al processo di transizione green. Il principale argomento per supportare questa ostilità è che il resto del mondo va per conto suo e non bada troppo, nei fatti, all’aumento globale della temperatura. A partire dagli Usa, il principale alleato storico dei paesi europei e il più importante mercato di sbocco, anche dopo i dazi. Donald Trump ha messo da parte le preoccupazioni per l’ambiente e spinge per trivellazioni e oleodotti anche nelle aree incontaminate. La Casa Bianca, inoltre, ha imposto alla Ue di importare a prezzo maggiorato 250 miliardi di dollari di energia americana all’anno. Con questo balzello l’Ue potrebbe dipendere dagli Stati Uniti per il 70% delle sue importazioni energetiche. Inoltre, si tratta di una enorme quantità di gas liquido da gestire (basti ricordare le proteste in Italia per i due terminal attivi) e che nei fatti nessuno sa come utilizzare.
Nell’altra parte del mondo si trova la Cina, il maggiore emettitore globale di Co2, con il carbone che rappresenta oltre il 50% del suo mix energetico. Inoltre, ha appena stretto un accordo con la Russia per un gasdotto che dovrebbe triplicare l’import. Non solo. La Cina oggi domina tutta la filiera delle rinnovabili: non solo sforna auto elettriche come fossero baguette, ma anche la quasi totalità di pannelli solari e batterie, oltre a essere leader mondiale nella lavorazione delle materie prime necessarie per le tecnologie dell’energia pulita. Per rendere l’idea: la Cina rappresenta oltre l’85% della fornitura globale di materie rare, con il 60% del litio e il 90% della grafite anodica mondiale. Insomma, senza la Cina non avremmo energia solare a prezzi accessibili o veicoli elettrici competitivi. Gli Stati Uniti, però, chiedono di alzare un muro verso Pechino. Insomma, l’Europa si trova stretta tra due fuochi. Senza la Cina i pannelli solari e le componenti per veicoli elettrici potrebbero aumentare i costi dal 30 al 50% e addio transizione green. D’altra parte, non è che Pechino, stretto alleato di Mosca, sia una garanzia per il futuro.
Sembrerebbe uno scenario che scoraggia qualsiasi velleità green. Ma bisogna aggiungere due considerazioni. La prima è che chi si proclama contrario alla transizione dimentica che ora l’Europa è comunque ostaggio dei produttori di petrolio e gas, dai paesi del Golfo fino all’Algeria. Se volessero chiudere i rubinetti sarebbero guai e, in ogni caso, prima o poi i giacimenti si esauriranno (sui tempi i pareri divergono) e bisognerà comunque contare sulle rinnovabili. La seconda considerazione è che proprio perché il fabbisogno energetico è condizionato da fattori esterni è bene diversificare le fonti. Infine, edifici che consumano meno o, meglio ancora sono autosufficienti, è la migliore garanzia per non arrendersi di fronte al diktat trumpiano e alla dipendenza dalla Cina.